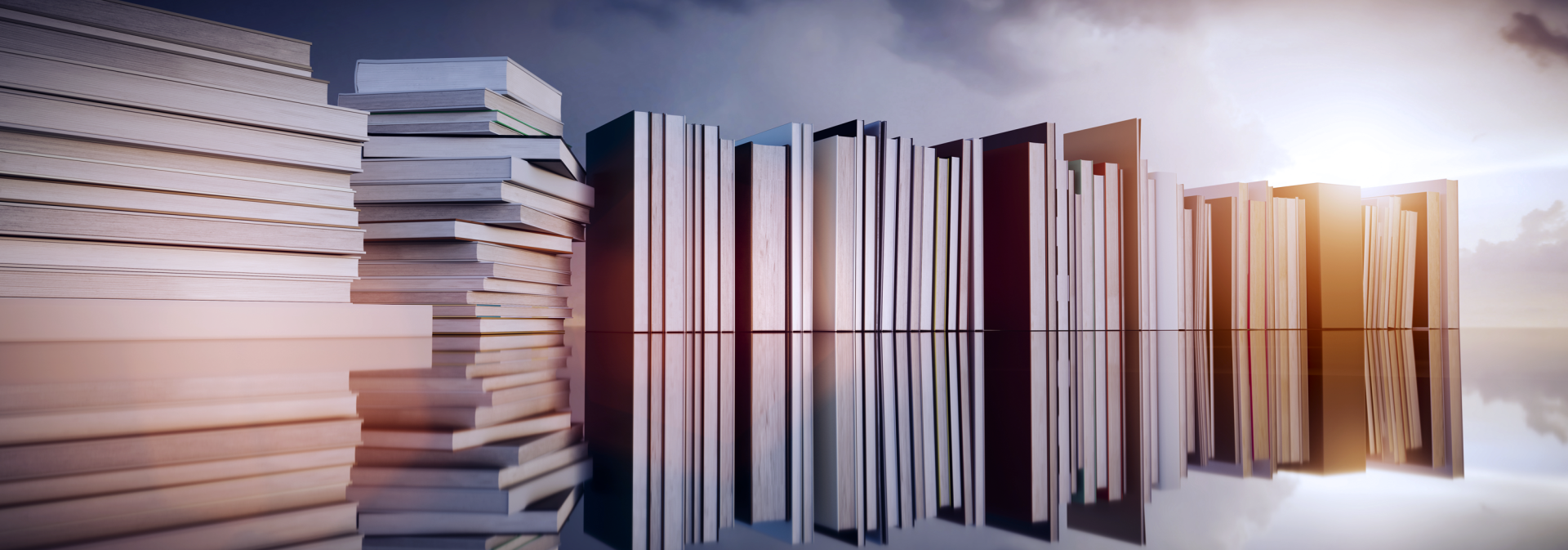studiolegalemanzini@gmail.com
ISTRUTTORIA SULLA DOMANDA DI CITTADINANZA. IL RIGETTO DELLA DOMANDA NON PUO’ LIMITARSI AD UNA MERA MOTIVAZIONE DI “STILE”
Spesso, il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto della domanda di cittadinanza italiana appare motivato - laddove il richiedente abbia non semplicemente qualche precedente penale ma anche solo un procedimento penale pendente e, pertanto in attesa di definizione – nel supportare il rigetto della domanda con motivazioni in serie che si possono sintetizzare nell’individuazione del generico e mancato presupposto della mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
Si tratta, per lo più, di motivazioni che appaiono il frutto di una sorta di clausola di stile tanto che, sovente, i decreti di rigetto delle istanza di cittadinanza appaiono frutto per lo più di un “copia e incolla”, che, tuttavia, non sottace l’evidente assenza di un’attività istruttoria adeguata a dimostrare, al di là di questo unico estemporaneo infortunio di carattere penale l’effettivo inserimento del richiedente nel tessuto sociale del Paese, l’Italia, del quale egli aspira a diventare cittadino.
Non si può non evidenziare come in tutte le fattispecie di concessione della cittadinanza, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, l’Amministrazione goda di un ampio potere di valutazione discrezionale circa l’esistenza di un’avvenuta integrazione dello straniero in Italia, tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunità nazionale.
Deve essere, infatti, richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa in tema di concessione della cittadinanza per cui un tale provvedimento non costituisce atto dovuto in presenza dei presupposti di legge, implicando una valutazione discrezionale dell’amministrazione circa la possibilità che lo straniero sia ammesso a far parte della comunità nazionale. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale, tale discrezionalità si esplica in un potere valutativo circa la avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto molteplici profili.
In particolare, la discrezionalità non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta.
La concessione della cittadinanza italiana – lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l’assenza di fattori ostativi – rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all’interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell’attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
Si tratta, altrimenti detto, di apprezzare, oltre alla residenza decennale ed all’inesistenza di fattori ostativi, la sussistenza di ulteriori elementi che giustifichino la concessione e motivano “l’opportunità di tale concessione”. E tanto anche al fine di evitare che, attraverso il conferimento dello status civitatis, lo straniero, che non rinuncia nel contempo alla cittadinanza di origine, possa divenire cittadino, pur non condividendo integralmente l’appartenenza alla Comunità nazionale.
Inoltre, essendo affidato ad una valutazione ampiamente discrezionale, il controllo demandato al giudice, avendo natura estrinseca e formale, non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.
In alcuni casi dei quali lo Studio si sta occupando, con conseguente impugnazione del decreto di rigetto al T.A.R. del Lazio, il provvedimento di diniego di concessione della cittadinanza italiana risulta motivato sulla base dell’intervenuto accertamento dell’esistenza di un procedimento penale pendente.
Ma è stata svolta, al di là della mera verifica del casellario giudiziale, un’attività istruttoria finalizzata ad accertare lo stato effettivo di inserimento del ricorrente nel tessuto sociale della realtà nella quale egli vive, sulla base degli evocati parametri giurisprudenziali?
Ad avviso del ricorrente la risposta è negativa.
Non sono state valutate minimamente le circostanze che hanno portato, dopo l’arrivo del richiedente in Italia, al suo effettivo inserimento nel tessuto sociale del luogo nel quale egli vive: spesso il ricorrente è venuto in Italia al seguito della famiglia di origine, ha comunque frequentato in Italia la scuola dell’obbligo e, completato il ciclo di studi, si è attivato immediatamente per la ricerca di un lavoro, risultando occupato a tempo indeterminato e senza soluzione di continuità. Il possesso di una stabile occupazione si è stato poi affiancato dalla formazione di un proprio nucleo famigliare in Italia, con l’inserimento dei figli minori nelle istituzioni della scuola dell’obbligo: tutti parametri di un’esistenza assolutamente regolare nella quale, un lontano infortunio penale, appare da solo propedeutico al rigetto della domanda di cittadinanza, senza un concreto apprezzamento di circostanze ulteriori e sostanziali riguardanti il profilo di vita del richiedente.
Peraltro, le fattispecie di reato che integrano i presupposti del rigetto della domanda, non sono comprese tra quelle che, ai sensi dell’art. 6, comma 1° della legge 91/1992 sono ostative alla concessione della cittadinanza; men che meno, vi è un giudizio di pericolosità sociale o per la sicurezza dello Stato sulla persona dei ricorrenti, giudizio suscettivo di infirmarne qualsiasi aspettativa al rilascio della cittadinanza.
Ora, la cittadinanza per residenza decennale, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992, si basa secondo l’interpretazione giurisprudenziale, sull’effettivo inserimento del ricorrente nella comunità nazionale. La concessione della cittadinanza italiana è atto ampiamente discrezionale, che non solo deve tenere conto di fatti penalmente rilevanti, esplicitamente indicati dal legislatore, ma che deve valutare anche l'area della loro prevenzione e, più in generale, della prevenzione di qualsivoglia situazione di astratta pericolosità sociale.
Il portato di discrezionalità che connota l’atto in questione implica accurati apprezzamenti da parte dell’Amministrazione sulla personalità e sulla condotta di vita dell'interessato e si esplica in un potere valutativo circa l'avvenuta integrazione dello straniero nella comunità nazionale sotto i molteplici profili della sua condizione lavorativa, economica, familiare e di irreprensibilità della condotta.
La conclusione che può trarsi da tali principi è quella per cui l'inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando quest'ultimo dimostri di possedere ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità e sia detentore di uno status illesae dignitatis morale e civile, nonché di un serio sentimento di italianità che escluda interessi personali e speculativi sottostanti alla richiesta di naturalizzazione.
Tuttavia, dove non sussistano – come nei casi dei quali lo Studio si sta occupando – esigenze di esplicazione sintetica delle motivazioni di rigetto dell’istanza in ragione della salvaguardia di attività preventive o di indagine, la portata dell’obbligo motivazionale ex art. 3 legge 241/1990 non può che riacquistare la propria capacità espansiva nella sua più ordinaria dimensione e, quindi, in termini proporzionati alla varietà delle circostanze meritevoli di considerazione nel giudizio discrezionale dell’Amministrazione.
Dal momento che per pacifica giurisprudenza il provvedimento di diniego non è sindacabile per i profili di merito della valutazione dell’Amministrazione procedente, esso tuttavia è sindacabile per i profili idi eccesso di potere derivanti dall’inadeguatezza della motivazione.
Quando, dunque, è assolto da parte dell’Amministrazione procedente, l’onere della motivazione sufficiente?
Il parametro non è rigido ed assoluto ma al contempo esso si presta ad essere adeguatamente calibrato in funzione, anche, della delicatezza degli interessi, pubblici e privati, coinvolti, che potrebbero ricevere pregiudizio già per effetto di un indiscriminato ed incontrollato palesamento dei fatti accertati dall’Amministrazione e degli strumenti istruttori utilizzati.
Non si legittima pertanto un assolvimento attenuato dell’onere di motivazione da parte dell’Amministrazione procedente dal momento che è ineludibile la distinzione tra motivazione del provvedimento di diniego - la cui estensione, ai fini della valutazione della sua sufficienza in concreto, deve essere perimetrata alla stregua dei principi che precedono - e sindacato di legittimità secondo il paradigma dell’eccesso di potere al cui esercizio concorrono tutti gli elementi istruttori acquisiti ed acquisibili, anche nell’esercizio dei poteri istruttori spettanti al giudice amministrativo, ovvero nel quadro dell’esercizio del diritto di accesso da parte dell’interessato .
Il provvedimento di rigetto, limitandosi ad affermare che “le vicende penali sopraindicate sono indice sintomatico di inaffidabilità del richiedente e di una mancata integrazione nella comunità nazionale” non fa alcun cenno alla condizione sociale del richiedente, al suo effettivo inserimento nel tessuto sociale della realtà nella quale egli vive, all’effettivo reperimento di una stabile occupazione e a mezzi legali di sussistenza, limitandosi a constatare in modo meccanicistico a fronte del fatto storico di reato la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente la concessione della cittadinanza italiana sul rilievo che il procedimento penale pendente « è comunque indice di inaffidabilità del richiedente e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale desumibile in primis anche dal rispetto delle norme di civile convivenza”.
Risulta del tutto obliterata, dunque, la valutazione di quegli ulteriori elementi quali la stabile attività lavorativa, l’inserimento del richiedente nel contesto familiare presente a Verbania con il quale il ricorrente vive, elementi che in ragione di una compiuta attività istruttoria avrebbero dovuto portare ad un necessario ed indefettibile apprezzamento ai fini del pieno e doveroso assolvimento dell’obbligo motivazionale.
Per quanto si possa ritenere che la condotta dei ricorrenti non sia stata del tutto irreprensibile, è stata dunque omessa ogni valutazione circa la contestualizzazione temporale dell’unica vicenda penale che li ha riguardato, vicenda che non concorre certo a formulare una prognosi di pericolosità sociale dei ricorrenti e che, per giunta, risale a quasi un decennio prima e non appare tale da macchiarne indelebilmente la condotta civile.
In siffatto contesto, l’Amministrazione non poteva, nel denegare il riconoscimento della cittadinanza per naturalizzazione richiesto ai sensi dell’art. 9 della l. n. 92 del 1991, fondare il proprio giudizio di mancato inserimento sociale sull’astratta tipologia del reato e sulla sua pericolosità, astratta o presunta, facendo emergere l’assenza di ogni valutazione in ordine alla effettiva e complessiva integrazione dello straniero nella società, rapportata ai suoi legami familiari, alla sua attività lavorativa, al suo reale radicamento al territorio, alla sua complessiva condotta che, per quanto non totalmente irreprensibile sul piano morale, deve comunque mostrare, perlomeno e indefettibilmente, una convinta adesione ai valori fondamentali dell’ordinamento, di cui egli chiede di far parte con il riconoscimento della cittadinanza.