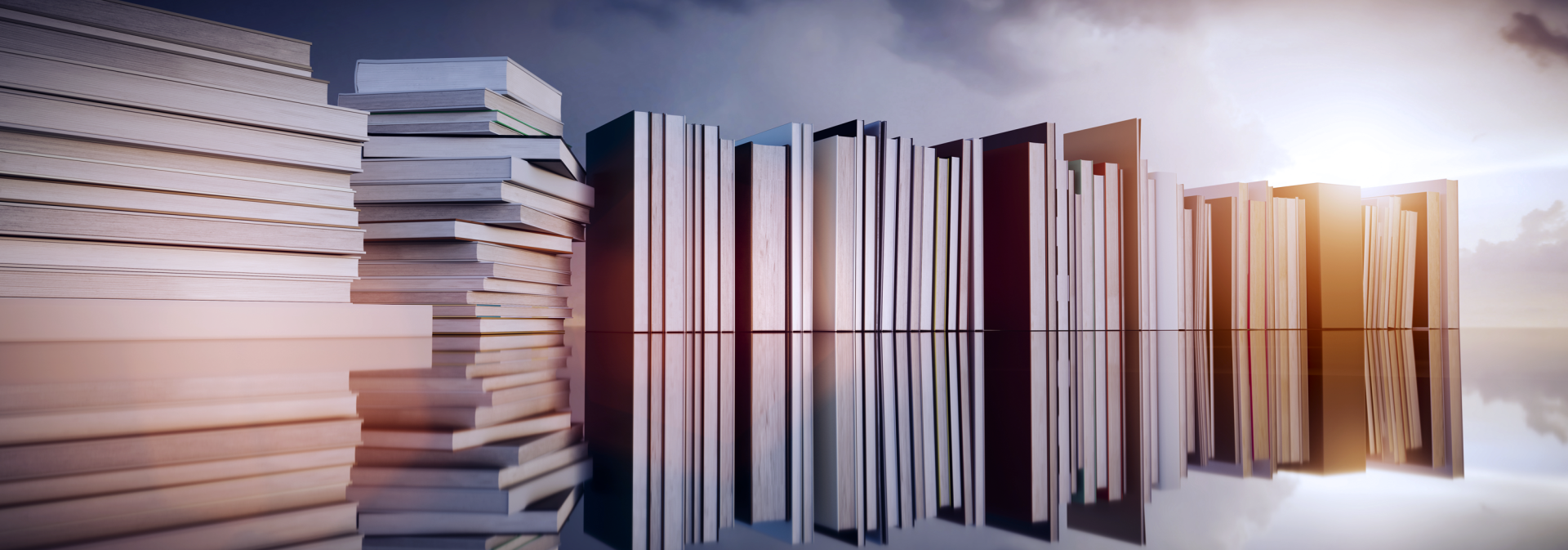studiolegalemanzini@gmail.com

Le cronache giudiziarie - sempre più di frequente purtroppo ma con una tendenza che risale agli albori di “Mani Pulite” nei primi anni Novanta - espongono le vicende relative alle indagini penali ed ai processi con modalità che non solo di frequente ledono l’immagine delle persone coinvolte a vario titolo nelle stesse indagini o nei processi, ma financo tendono a presentare le stesse persone come i colpevoli più o meno certi, da sottoporre così al giudizio pressochè insindacabile dell’opinione pubblica.
Lo “stile” giornalistico, spesso presenta le singole vicende, tante volto solo in una fase meramente investigativa, come realtà già concluse, nelle quali colui che è solo indagato viene già dipinto come il colpevole; si sa che i titoli ad effetto dei giornali fanno vendere copie, ma si spesso ignora che in quei titoli e in quegli articoli si parla di persone che vivono anche con intensa sofferenza le vicende che li riguardano.
E ciò è assai grave ove si consideri il fatto che, proprio perché si è in una fase investigativa, assai rigorosi dovrebbero essere gli strumenti a tutela dell’indagato. Non casualmente, infatti, il Codice di Procedura Penale prevede che eventuali atti notificati all’indagato, quali l’informazione di garanzia costituiscano strumenti a “tutela” dell’indagato stesso che, ricevuta la notifica di tale atto è messo nelle condizioni di apprendere che si stanno svolgendo indagini sul proprio conto e che, pertanto, potrà esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, presentando memorie difensive, chiedendo di essere interrogato o addirittura svolgendo indagini difensive a propria discolpa.
Eppure, uno strumento di mera tutela dell’indagato, se in spregio alle esigenze di stretto riserbo finalizzate a garantire il segreto istruttorio nello svolgimento delle indagini, può trasformarsi, attraverso la divulgazione mediatica della notifica dell’atto, o magari anche di verbali di interrogatorio che dovrebbero essere appunto – lo si ribadisce - coperti dal segreto istruttorio, in una specie di giudizio di condanna preventivo, senza che poi possa sortire alcuna efficacia riparatoria l’eventuale notizia (spesso data dallo stesso organo di stampa in una pagina interna e con un semplice trafiletto) dell’eventuale assoluzione nel processo o, addirittura, dell’eventuale archiviazione dell’indagine, circostanza quest’ultima che rende semmai ancor più censurabili certi comportamenti massmediatici.
Il tutto per soprassedere inoltre alle spesso assai frequenti inesattezze di carattere tecnico - procedurale alle quali si espongono gli autori degli articoli di cronaca giudiziaria che, dovendosi cimentare nell’esporre fatti o notizie la cui natura implica un’interpolazione con l’applicazione delle procedure giudiziarie, dovrebbero anche dimostrare di conoscere almeno le basi del codice di procedura penale, nella parte in cui esso è esplicativo delle varie fasi e sequenze delle indagini e dei processi. Eppure ciò non accade, con implicazioni inevitabilmente negative.
E’ di tutta evidenza come rispetto ad una problematica come quella in esame, tendano a fronteggiarsi ed anzi a contrapporsi interessi spesso assai diversi tra loro quali da un lato il dovere di informazione, strettamente connesso all’esercizio del diritto di cronaca e, dall’altro, lo svolgimento dell’attività investigativa, strettamente connesso all’esercizio dell’amministrazione della giustizia e, specificamente, della funzione giurisdizionale.
Interessi contrapposti il cui bilanciamento non sempre appare facile in quanto l’ambito mediatico e quello giudiziario tendono necessariamente ad incontrarsi su un terreno comune nel quale interagiscono diversi soggetti, al di là degli indagati e degli imputati: gli avvocati, i pubblici ministeri titolari delle attività di indagine, il personale delle sezioni di polizia giudiziaria preposto su delega del Pubblico Ministero al compimento degli atti investigativi ed infine gli stessi giornalisti.
Il richiamo, come pure spesso avviene alla c.d. “presunzione di innocenza”, secondo il quale l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, peraltro sancita dall’art. 27 della Costituzione rischia di essere una mera petizione di principio laddove concretamente non siano adottate una serie di misure e di strumenti che, nel corso dell’iter temporale spesso assai lungo tra l’apertura di un’indagine, la sua successiva conclusione con il rinvio a giudizio dell’indagato, lo svolgimento dell’udienza preliminare laddove prevista, il primo grado di giudizio, l’appello ed infine il passaggio in Cassazione, vedano fattivamente applicato tale principio di civiltà giuridica.
In questo contesto si inserisce, per l’appunto, l’importante novità scaturita dalla direttiva dell’Unione Europea, di recentissima approvazione, finalizzata a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza.
In primo luogo la direttiva afferma un nesso tra il Trattato sull’Unione Europea e la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali laddove afferma che l'articolo 6, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.
L’obiettivo primario della direttiva è delineato nell’esigenza di potenziare le garanzie giuridiche che tutelano le persone coinvolte in procedimenti avviati dalla Procura europea ma è di tutta evidenza che, dovendo essere recepita dagli Stati membri nei rispettivi ordinamenti interni, la direttiva verrà ad incidere direttamente nella tutela delle persone coinvolte in procedimenti penali negli Stati membri, davanti alle rispettive autorità giudiziarie.
Preme osservare in primo luogo come il principio della presunzione di innocenza si sia sviluppato nel corso degli anni.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha stabilito che l'articolo 6, paragrafo 2, della CEDU contiene tre condizioni fondamentali[1]: il diritto di non essere presentato pubblicamente dalle autorità come condannato prima della sentenza definitiva[2], il fatto che l'onere della prova incombe alla pubblica accusa e che qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza deve valere in favore dell'imputato, e il diritto di quest'ultimo di essere informato delle accuse nei suoi confronti.
La Corte riconosce altresì l'esistenza di un legame evidente tra la presunzione di innocenza e altri diritti a un equo processo, nel senso che laddove questi siano violati, la presunzione di innocenza è a sua volta inevitabilmente a rischio: il diritto di non incriminarsi, il diritto di non cooperare e di restare in silenzio[3] e il diritto alla libertà (e conseguentemente di non essere assoggettati a custodia cautelare)[4].
La direttiva, accanto alla presunzione di innocenza richiama altresì il diritto di presenziare al processo, il diritto di essere informato dell’accusa – normato dalla direttiva 2012/13 e pertanto non rientrante in questa direttiva.
Stabilito che la direttiva si applichi all’indagato o all’imputato a partire dall’avvio del relativo procedimento penale, anche prima che l’indagato sia messo al corrente dalle autorità competenti del fato di essere indagato o imputato per un reato, la direttiva richiama una statuizione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo[5] nella parte in cui essa ha definito come aspetto fondamentale del principio della presunzione di innocenza il fatto che né un giudice né un funzionario pubblico possano pubblicamente presentare un indagato o un imputato come colpevole di un reato se questi non sia stato processato e condannato per tale reato con sentenza definitiva. Principio che dovrebbe estendersi a tutte le autorità pubbliche.
La direttiva prende posizione in tema di onere della prova affermando che la presunzione di innocenza faccia ricadere sull’accusa l’onere della prova e che qualsiasi dubbio in merito alla colpevolezza debba valere nei confronti dell’indagato o dell’imputato. La decisione del giudice deve quindi fondarsi su prove fornite e non su mere accuse o supposizioni. A protezione dell’imputato nel processo, la direttiva afferma il diritto di non incriminarsi e di non cooperare e il diritto al silenzio.
Si tratta di diritti consustanziali al concetto di equo processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU e che sono strumentali a proteggere l’indagato e l’imputato dall’indebita coercizione dell’autorità, contribuendo ad evitare errori giudiziari. non casualmente, infatti, il grado di coercizione esercitata sull’indagato o sull’imputato per costringerlo a fornire informazioni in merito alle accuse contro di lui non può, compromettere l’essenza stessa del suo diritto di non incriminarsi e del suo diritto al silenzio.
Il diritto di non incriminarsi è finalizzato a rispettare la volontà dell’indagato o dell’imputato di non rispondere ed implica che la pubblica accusa possa raccogliere elementi contro l’indagato o l’imputato senza ricorrere a prove ottenute mediante metodi coercitivi od oppressivi: la portata applicativa di questo diritto non fa riferimento semplicemente ai casi nei quali la coercizione abbia pesato sull’imputato, al contrario il diritto in questione costituisce un corollario della presunzione di innocenza di cui all’art. 6 della CEDU.
Il diritto a rimanere in silenzio, nel quadro del sistema di tutela dell’indagato e dell’imputato si concretizza, come sancito dalla direttiva 2012/13/UE nell’obbligo di informativa immediata sia del diritto stesso sia del contenuto e della eventuali conseguenze derivanti dall’esercizio del diritto o dalla rinuncia allo stesso. Un passaggio importante, rispetto all’esercizio di questi diritti è l’affermazione per cui è da escludere che dall’esercizio di questi diritti possano trarsi conclusioni nei confronti dell’indagato o dell’imputato.
Questi ultimi non devono temere che la mancanza di cooperazione da parte loro od il loro silenzio possano essere usati contro di loro nelle fasi successive del procedimento penale: solo in questo modo può essere assicurata all’indagato ed all’imputato una piena capacità di esercizio di questi diritti. Ed a tutela di tale principio la direttiva vieta l’uso si prove ottenute in violazione di questi diritti. La direttiva, sul punto, tuttavia non preclude agli Stati membri di tener conto dell’eventuale comportamento cooperativo dell’indagato o dell’imputato nel momento in cui dovrà essere concretamente decisa la pena da comminarsi.
Completano la “costruzione” del principio della presunzione di innocenza l’affermazione del diritto dell’imputato a presenziare al proprio processo, al fine di non compromettere l’esercizio del diritto di difesa, ribadendo che le eventuali eccezioni a tale diritto di presenziare debbano essere estremamente circoscritte e che, in ogni caso, allorchè gli Stati membri applichino procedure semplificate per i reati minori, la semplificazione della procedura adottata non possa pregiudicare il diritto dell’imputato di presenziare al processo.
La parte conclusiva della direttiva, rubricata “principio di sussidiarietà” appare fondamentale in quanto esplica il senso dell’intervento del legislatore europeo: quest’ultimo, infatti, ha colto la sensibilità differente con la quale nei vari Stati membri viene applicato il principio della presunzione di innocenza di tal che la stessa giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo ha potuto constatare come le violazioni di tale principio siano frequenti, per giunta in un contesto di riluttanza degli Stati membri a cooperare tra loro.
Vi è dunque, alla base dell’intervento del legislatore europeo la consapevolezza di un’insufficienza dell’intervento della Corte a tutela dell’applicazione di questo principio al punto che la direttiva si prefigge l’obiettivo di introdurre una serie di norme minime comuni ed applicabili nell’intera Unione Europea, avvicinando così le norme procedurali in vigore negli Stati membri.
NOTE
[1] Sentenza 6 Dicembre 1988 Barberà, Messeguè e Jabardo c. Spagna
[2] Sentenza 25 Marzo1983 Minelli c. Svizzera
[3] Sentenza 25 Febbraio 1993 Funke c. Francia
[4] Sentenza 26 Ottobre 2010 Kudla c. Polonia
[5] Sentenza Minelli c. Svizzera